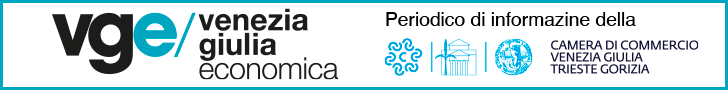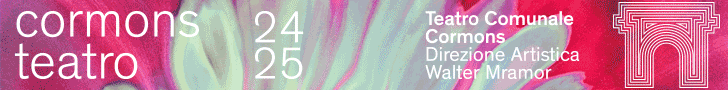l'intervista
La regista Maja Weiss e quei confini da superare, «le donne slovene e il cinema»

Prima donna slovena ad aver realizzato un film nel proprio Paese, Maja Weiss racconta la sua arte e le sue ispirazioni: dal Neorealismo a Trieste.
Prima donna slovena ad aver realizzato un film nel proprio Paese, Maja Weiss è un’artista straordinaria e piena di coraggio, che ha avuto la forza di irrompere sulla scena a 35 anni come regista. Sia pure un’età tardiva rispetto ai colleghi maschi, fu un primo segno di apertura e trasformazione della Jugoslavia, forse premonitore di quella identità dalla quale sarebbe risorta anni più tardi la Slovenia. Dopo un’infanzia trascorsa a Metlika e gli studi di regia, è giunta alla ribalta con il film “Guardian of the frontier”. Nei giorni scorsi ha presentato al Palazzo del cinema di Gorizia il suo “Raccolti alla fonte – I bambini sloveni di Lebensborn”.
Com’è nato il suo amore per il cinema?
Da bambina abitavo a Metlika, nella Jugoslavia socialista, in una piccola cittadina confinante con la Croazia. Avevamo un televisore in bianco e nero con soli due canali, sloveno e croato. I miei genitori adoravano i film, mio padre conosceva la storia del cinema e le colonne sonore, aveva libri di cinema nei quali per la prima volta ho potuto apprezzare le foto delle troupe sul set. Eravamo tutti seduti a guardare la tv. Film nei quali veniva “mostrato il mondo fuori”.
Ricordo i successi italiani sul Neorealismo, con Vittorio De Sica, Roberto Rossellini. Erano storie impregnate di passione ed esistenzialismo. Attori grandiosi, come Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Anna Magnani. In una sala a due minuti da casa mia davano film contemporanei. Ricordo ancora “La signora del blues” (1972), Billie Holiday e gli spaghetti western, li ho adorati. Più tardi, in una scuola di Lubiana, ne ho girato uno da me, un corto intitolato “Pistoleri balcani” (1992). Con cui ho partecipato al mio primo festival del cinema di Edimburgo, rilasciando la mia prima intervista all’estero, sulla guerra in Jugoslavia.
Come ci si sente a essere la prima donna ad aver diretto un film in Slovenia?
Ho avuto l’opportunità di farlo quando avevo già 35 anni, dopo aver girato numerosi documentari, e il cortometraggio “Adrian”, che ha ottenuto numerosi premi internazionali. Gran parte dei registi della mia generazione lo avevano fatto molto prima, mentre le donne non avevano opportunità. In seguito – nel 2000 - avrei finalmente girato il primo lungometraggio di finzione, ne ero entusiasta. È stato girato durante l’estate più bella della mia vita.
La troupe era come una famiglia, e per la prima volta io e mia sorella Ida abbiamo prodotto assieme un film con la Bela film, da noi fondata. Grazie a fondi sloveni e in coproduzione con la tedesca Taris film, “Guardian of the frontier” è stato il primo film incentrato sulle donne slovene, con tre protagoniste: Iva Kranjc, Pia Zemljič e Tanja Potočnik. È la storia di tre donne che fanno una gita in canoa sul fiume Kolpa, fra la Slovenia e la Croazia. Un thriller fantasy che esplora confini diversi, geografici, nazionali, politici, di genere, confini di linguaggio, del sesso. A disposizione avevo una grande troupe internazionale.
Il cameraman era Bojan Kastelic, che ha lavorato con me dal 1990, mentre la colonna sonora è stata prodotta da Peter Braatz, montatore e anche mio marito. Il film è stato proiettato al Festival del cinema di Berlino nel 2002, l’anno successivo alla nascita di mia figlia Larissa. Mio figlio August Adrian Braatz – che allora aveva sei anni – recitava nella parte del figlio del guardiano. Oggi anche lui è un regista. Jonas Žnidaršič - che interpretava il Guardiano - oggi siede in Parlamento. Marjan Šarec, che aveva un ruolo in una parte minore, è l’attuale ministro della difesa.
Šarec non ama questo film, anche se ha riscosso un grande successo internazionale, ricevendo premi e venendo trasmesso nelle tv d’Europa. Un film provocatorio e femminista. Se intorno al 1948 è stato girato il primo film da uno sloveno, è solo nel 2002 che è uscito il primo lungometraggio girato da una donna. La cosa bella è che il giorno delle riprese sono arrivate cinque giovani registe. Hanna Slak – il cui ultimo lungometraggio è stato presentato in anteprima nel 2023 al Toronto film festival - mi ha consegnato a nome di tutte una t-shirt con l’immagine di una donna che solleva pesi, con la scritta “Stiamo arrivando”. Un’allusione al potere della donna slovena, che darà il via a un grande cinema.
Come si inserisce “Guardian of the frontier” nella realtà odierna?
Dopo 25 anni, è ancora un film moderno e interessante, mostrando gli stessi problemi attuali diffusi nel mondo. I giovani lo adorano, sia in patria che all’estero. Il GoEast Wiesbaden film festival dello scorso anno è stato l’ultimo evento in cui si è rimarcato come sia di estrema attualità, quasi fosse stato girato oggi. Ne sono felice, soprattutto perché sono ormai quindi anni che non ho più realizzato film. I miei progetti sono stati rifiutati per ben sei volte, dalla Commissione fondi slovena. È davvero doloroso. Si stanno facendo largo le nuove generazioni, non ci sono molti fondi disponibili, così i registi più vecchi vengono emarginati. Ma ci riproverò comunque!
Lei ha girato anche “Trieste on the border”. Come vede le relazioni fra Paesi confinanti? C’è una pace possibile, in Paesi di confine come Italia e Slovenia, che possa rappresentare un esempio per il resto del mondo?
Il documentario venne girato nel 1995, quando la Slovenia era appena diventata un nuovo Stato (1991), ma non era ancora entrata nell’Unione Europea. Quindi il confine era ancora lì. In città è da sempre presente la comunità slovena. Trieste è una città bilingue, con due culture, italiana e slovena. Multiculturale, dove ebrei, tedeschi, ungheresi, piccole minoranze o religioni diverse già allora vivevano la propria vita e costruivano la città assieme. Naturalmente non è avvenuto senza problemi.
Il fascismo e la Seconda guerra mondiale – unitamente alla politica di Mussolini – distrusse radicalmente tutto questo. I sostenitori dell’ideologia nazionalistica dell’odio hanno commesso atti terribili contro la minoranza slovena, ormai è storia. Ma quello che mi interessava nel 1995 era che in quegli anni la città fosse esempio di città multinazionale, tollerante e culturale. Non solo ho intervistato il sindaco Riccardo Illy, ma ho potuto incontrare i più grandi scrittori – oggi diremmo influencer – di Trieste, da Claudio Magris a Fulvio Tomizza, Boris Pahor, Alojz Rebula. Ricordo ancora con quale amore si riferissero a un’Europa centrale, dove tutte queste diverse culture e nazionalità non solo convivono insieme, ma si influenzano a vicenda scambiandosi ogni giorno una “cultura quotidiana”, compreso ricette e frutti della terra.
L’espressione “Europa centrale” allude alla cultura spirituale degli Stati del Centro Europa sotto ogni aspetto, dall’arte alla letteratura al cinema e tanto altro. Trieste era una Mitteleuropa! Per me era sinonimo di ciò che Lubiana dovrebbe diventare in futuro. Multiculturale, multinazionale e multireligiosa. Oggi siamo vicini come non mai. A dicembre mi trovavo al Teatro Miela di Trieste con mio marito, per ascoltare un concerto, dove ho trovato un articolo su un corso di lingua slovena per italiani e stranieri. Un buon segno. Dal 2004 insieme all’Unione europea abbiamo firmato per l’apertura delle frontiere, dell’istruzione, del lavoro.
Gli italiani possono venire di qua e gli sloveni dall’altra parte – se conoscono la lingua – Poi abbiamo il problema dei migranti, che dobbiamo affrontare insieme. Senza dimenticare che tutti noi lo siamo stati. Il confine sloveno è aperto a Trieste e Gorizia come altrove, e ci si augura che resti tale!
Quale messaggio intende trasmettere, “I bambini di Lebersborn”?
Il documentario racconta la storia di trenta bambini sloveni rapiti, selezionati attraverso i canoni razziali e inseriti nel programma Lebensborn, per essere dati in adozione e cresciuti secondo l’ideologia nazista. In primo piano vi sono le vite di quattro bambini, che oggi vivono in diverse parti del mondo. Madri morte ad Auschwitz, padri fucilati perché avevano preso parte alla resistenza. Ma si parla anche di amore, perdono, e di una nuova generazione che trascende gli schemi di appartenenza. Il film intende trasmettere il messaggio che è necessario essere tolleranti verso gli altri, scendere a compromessi e lottare per un dialogo di pace.
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram e Whatsapp, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione