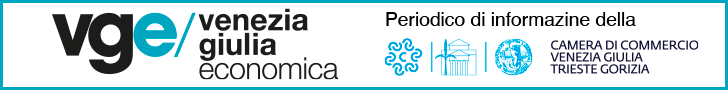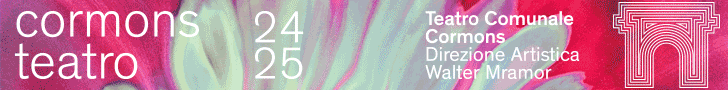a gorizia
Le donne nel patriarcato, i mondi diversi di Fusaro e Gancitano a èStoria

L'incontro a tre voci ieri in Tenda Erodoto, le evoluzioni della figura maschile. Il filosofo: «Non si può risolvere la famiglia nel patriarcato».
“Che cos’è il patriarcato?”. Con la domanda di Fabio Vander ha avuto inizio la conferenza che si è svolta ieri a Gorizia, nell’ambito di èStoria. Laureato in filosofia teoretica e storia contemporanea, Vander coordina la segreteria di Liliana Segre al Senato. “Il termine deriva dal greco antico πατριάρχης (patriarkhēs), 'padre di una razza’”, ciò che delinea una sorta di “centralità della figura maschile nell’organizzazione sociale, in tutte le epoche storiche”. Il concetto presuppone una gerarchia. “C’è stato un tempo in cui invece era la figura femminile, a prevalere, anche se alcune pensatrici, come la De Beauvoir, negano il matriarcato”.
Nella società greca era netta, la centralità dell’uomo, mentre nell’antica Roma, con la nascita del diritto, abbiamo il pater familias, dove l’uomo è il dominus, o la patria potestas, in quanto si immagina che l’uomo sia maggiormente adatto a dettare le regole della vita civile. Anche la modernità si struttura a partire dalla figura maschile, poiché “oggi più che mai la società liberista è conflittuale, gerarchizzata”. È stato poi il movimento femminista a richiedere “una riorganizzazione paritaria, ma è una battaglia di lungo periodo che ci vedrà impegnati per i prossimi decenni”. Si sono poi intercalati dei mutamenti dovuti alla rivoluzione industriale.
“Maya De Leo, nel suo ‘Queer’, spiega come sia nata un’idea di sessualità diversa”, ha commentato Maura Gancitano, in quanto “mettere in discussione il modello patriarcale significa mettere in discussione che i generi siano solo due”. Allora esistono “maschi genetici e femmine genetiche”, mentre l’1% è intersex. “Quello che fa la medicina è associare un genere che potrebbe non essere quello giusto”. A intervenire è poi il filosofo Diego Fusaro, ricalcando la natura antica del termine: “Quando si parla di patriarcato si parla di lunghissima parte della nostra storia. Il potere fonda le radici nella nostra storia e trova le radici nei più grandi pensatori”, i quali presuppongono una “superiorità dell’uomo”, come afferma Aristotele.
In questo senso la donna appare ombra dell’uomo, “ha un ruolo ancillare”. Di fatto la polis è abitata da uomini, adulti, greci ateniesi. Diversamente Platone, che oscilla fra due posizioni come nel “Timeo”, riconoscendo “l’ontologica superiorità dell’uomo” e teorizzando nella città di Kallipolis gli stessi diritti per entrambi. Il patriarcato è stato anche “un modello di organizzazione politica”. La modernità capitalistica propone invece nuove figure, “quella del modello capitalistico in cui la figura del Padre padrone è centrale”. E tuttavia il capitalismo sta mutando forma. Lo aveva già colto Pasolini, assistendo alla genesi di una “società dei consumi” ancora più repressiva.
Nei suoi “Scritti corsari” si comprende come “si stava passando da una società clerico-fascista a una edonistica che doveva abbattere la figura del padre”. Una sorta di deregolamentarizzazione, ma “è il capitalismo stesso che va incontro a una società di libero consumo post patriarcale”, aggiunge Fusaro. Con il ’68 la trasformazione del capitalismo è andata nella direzione di “un desiderio che prende il sopravvento sulla legge”. Con la nascita di una società ”in cui non vige più l’imperativo di Kant ‘tu devi’, ma solo quello consono a De Sade ‘tu devi godere’, del ‘life is now’, che è poi il motto della società di mercato”.
Quella che Zygmunt Bauman definisce “società liquida” iper-individualista e priva dell’idea di comunità. “Non è forse vero che il capitalismo non ha più bisogno della religione?”, domanda Fusaro. Ecco che torna la “società atomizzata dei consumatori indistinti”, come diceva Pasolini. Il capitalismo genera un “laissez faire integrale”, ma la soluzione non sta nel combattere contro il patriarcato, perché significherebbe “combattere contro un nemico che tende a evaporare”. E spiegando la visione di Hegel, cioè che “il capitalismo produce una società di mercato integrale”, osserva come le corporazioni stanno evaporando “come la scuola pubblica”.
Una società di mercato, quella attuale, “abitata da un pulviscolo di consumatori” che vedono lentamente disgregarsi gli enti pubblici e la famiglia stessa. “Non si può risolvere la famiglia nel patriarcato, che è una patologia della famiglia”, occorre distinguere i due concetti. Fusaro ha poi concluso come “l’odierno capitalismo sta producendo un nuovo ordine erotico di individui avulsi da ogni famiglia, condannati a vivere nell’erranza”. Non siamo più in un romanzo di Balzac, siamo dei “globetrotter educati a essere contrari a ogni relazione”. Occorre evitare, poi, l’errore di cancellare la differenza fra uomo e donna “producendo un individuo unisex”.
Il rischio è una società di “atomi competitori”, quindi la lotta contro il patriarcato tende a essere obsoleta. La differenza di genere, secondo Fusaro, si determina solo in 3 ambiti: sesso, che è per natura; genere, che esprime il modo culturale in cui si declina; gusto sessuale. Non dobbiamo confondere l’uno con l’altro. Abbiamo poi interrogato il filosofo su altre tematiche non affrontate durante la conferenza.
Filosofo a 16 anni: è un sogno diventato realtà, che ancora oggi dirige.
Diciamo che è stata una passione precoce, ho capito che quello dovevo fare nella vita, e ho assecondato il mio sogno, ho continuato a fare quello ed è una di quelle cose che non si smette mai di fare, perché come dice Epicuro, non è mai presto e nemmeno tardi, per fare filosofia.
Perché “odio la resilienza”?
Odio la resilienza perché la resilienza è la parola chiave del potere, oggi, che ci vuole resilienti, cioè tali da sopportare tutto e da cambiare noi stessi e mai il mondo. Resiliente è colui il quale anziché cambiare il mondo oggettivo, cambia se stesso per sopportarlo meglio, fa un po’ come Paperino nei cartoni animati, che prende botte su botte e va avanti senza mai mettere in discussione ciò che lo fa cadere.
“L’essenziale è rimanere fedele al proprio scopo”. Qual è lo scopo dell’umanità, secondo lei?
A mio giudizio lo scopo dell’umanità è divenire finalmente consapevole della propria libertà e attuarla in maniere corrispondenti nel mondo oggettivo, quindi il lavoro dello spirito, per scomodare una categoria di Hegel, è quello di divenire sempre più consapevole, sempre più libero, e non si può essere liberi senza la consapevolezza, ecco perché la filosofia in un modo o nell’altro è sempre chiamata in causa.
Foto Daniele Tibaldi
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione