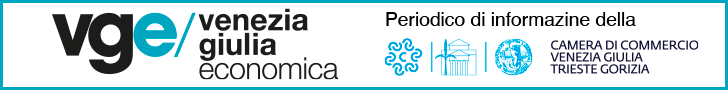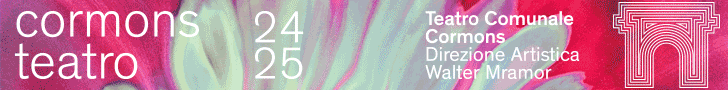L'APPUNTAMENTO
L’arte è lo specchio del nostro tempo: ‘Parigi’ raccontata da Jacopo Veneziani a Cormons

L’atto unico è in programma mercoledì 29 gennaio con la regia di Pietro Grandi e le musiche di Antonio Rimedio.
Intrappolata in ogni goccia di pioggia, la Tour Eiffel si scompone in mille lacrime oltre le finestre dei palazzi. Fra nuvole e squarci di sole Notre Dame accoglie i fedeli nel suo rinnovato splendore, mentre il SacréCoeur svetta da Montmartre, in cima ai vicoli che lo abbracciano. Parigi incanta e affascina da secoli artisti e intellettuali, ed è raccontando quest’incantesimo che Jacopo Veneziani ha deciso di allestire lo spettacolo che andrà in scena mercoledì sera alle 21 presso il teatro di Cormons, con la regia di Pietro Grandi. Un atto unico accompagnato dalle musiche di Antonio Rimedio e dalla scenografia live painting dell’illustratore Gabriele Pino, che proietterà il pubblico in un affascinante viaggio a ritroso nella Ville Lumière per arrestare le lancette agli inizi del Novecento. Ed eccola in tutta la sua affascinante bellezza, la Parigi con i suoi atelier e caffè, quella che Gertrude Stein definirà «il luogo in cui bisognava essere per essere liberi».
A intingere direttamente il pennello nel tubetto sarà Henri Matisse, che con i suoi colori vibranti e accesi infuocherà le tele con la spregiudicatezza dei Fauves. Mentre il vorace e insaziabile Pablo Picasso prenderà a scomporre le opere di El Greco e Poussin, in un’implosione di colori e forme geometriche. Non mancheremo di assistere alla famosa cena presso l’hotel Majestic - dove Picasso si ritroverà a tavola con James Joyce, Marcel Proust, Sergej Djagilev e Igor Stravinskij – o sedere al Café de Flore, in cui Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir daranno vita all’esistenzialismo. Storico dell’arte e divulgatore poco più che trentenne, Veneziani insegna “Comunicare l’arte” presso l’università IULM di Milano ed è ospite fisso al programma di Massimo Gramellini “In altre parole”, in onda su La7.
Sei giovanissimo, hai bruciato tutte le tappe…
In realtà non ho quest’impressione, nel senso che il mio primo tentativo di raccontare l’arte a persone che andassero oltre la cerchia di amici, familiari o vicini di biblioteca all’università, risale a quando aprii il mio primo profilo social nell’ormai preistorico e lontanissimo 2015, quando non avevo nessun tipo di visibilità. Sono dieci anni che provo a raccontare qualcosa a qualcuno, ho una visione più lenta. E comunque sono prudente, cauto, nel proiettarmi nel futuro. Mi ritengo fortunato, ma non mi sento s’un’auto lanciata in corsa, quanto – piuttosto – un escursionista di montagna che segue il suo sentiero e cerca di non cadere nel precipizio, approfittando ove possibile di godere del panorama.
Per la stesura di “La grande Parigi. 1900 – 1920” sei stato influenzato da “I segreti di Parigi” di Augias. Tu ci hai trascorso otto anni, come dottorando alla Sorbona. Com’è viverla, vederla risvegliarsi alla mattina o illuminarsi al tramonto?
È un’esperienza straordinaria, ti fa sentire più intelligente di quello che sei, perché ti svegli e dici “Forse dovrò fare delle grandi cose, come chi mi ha preceduto”. Poi, molto rapidamente sei riportato verso il mondo reale, la vita quotidiana e le cose che devi fare ogni giorno per sopravvivere. Per chi studia arte e storia crea un senso di frustrazione, proprio perché è una città in cui hanno vissuto grandissimi nomi dell’arte, della musica e della letteratura. In qualsiasi angolo di strada o caffè sei lì a chiederti “Chissà chi è passato in questa strada, chi si è seduto qui, chi viveva in questo palazzo”. È una città che continua a rimandare al proprio passato, un passato molto presente e ancora percepibile. Un mix di emozioni e sensazioni, sia rivolte verso l’istante presente che verso il passato, che ti fa venire voglia di approfondire la storia di tutto ciò che ti circonda.
L’alchimia della Ville Lumière è un segreto che continuamente sfugge. È il suo essere irriducibile, che ha affascinato e continua ad ammaliare intellettuali e artisti?
Secondo me un po’ sì, nel senso che Parigi è un po’ come una persona enigmatica e misteriosa, che ti intriga. Ti fa venire voglia di approfondire la sua conoscenza. Proprio perché ha un lato inafferrabile, ti chiedi quali siano le altre cose da scoprire, quindi è un’alchimia molto stimolante, per chi ci vive.
Che ruolo deve avere, l’arte, nella società contemporanea?
Credo che, come in ogni tempo, debba essere uno degli strumenti a nostra disposizione per interpretare il mondo in cui viviamo, capire quali siano vizi e virtù del nostro tempo, le nevrosi. L’arte è una sorta di specchio del nostro tempo, come è sempre stata. Vedi un’opera realizzata in un certo periodo storico, e attraverso questa comprendi una serie di elementi del periodo che l’ha generata. L’arte, soprattutto quella contemporanea, dovrebbe essere una sorta di bussola che ci consenta di orientarci nel mondo - fatto sempre più di immagini - per capire meglio il mondo e noi stessi.
Chi è Lolo?
È un asino che gioca un ruolo fondamentale nella storia dell’arte parigina di inizio Novecento, ma non lo spoileriamo. Diciamo solo che ha quasi messo in crisi il mondo delle avanguardie, e ha sfidato i grandi avanguardisti del tempo come Picasso, Modigliani e i futuristi.
Tremonti disse “Con la cultura non si mangia”. Sei d’accordo?
Dipende. C’è il rischio – ahimè – di non mangiare con la cultura fine a se stessa. Lo dico anche ai miei studenti all’università: quando si studia qualcosa è necessario sempre chiedersi come possa essere utile nel presente. Ok studiare le orecchie degli angeli nel Quattrocento della pittura marchigiana, ma come posso mettere in pratica questo patrimonio di conoscenze, oggi? Con la cultura non si mangia se la si tratta come una sorta di teca ermetica isolata dal resto del mondo. Alcuni dimenticano di vivere in un determinato tempo, finendo assorbiti dai propri studi storico-artistici. Quando ti lasci assorbire e trasportare in un altro mondo, dimentichi quello in cui vivi e le sue logiche, rischiando di rimanerne fuori. Con la cultura si riesce a mangiare se la si rende parte integrante del nostro presente: per vivere meglio nel mondo in cui si vive e sottolineare i legami fra la cultura e il tempo in cui viviamo.
Nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, l’opera d’arte da un lato diviene feticcio, dall’altra corre il rischio di diventare oggetto da fotografare e archiviare; come la “Monna Lisa”, ogni giorno catturata dalle fotocamere dei cellulari di migliaia di visitatori. Ma quanti riflettono davvero sul suo ineffabile sorriso e sul senso di ogni opera d’arte?
Spero tanti, e temo pochi. Quando visitiamo i musei ormai abbiamo un approccio consumistico. Alcuni lo visitano come se fossero al supermercato, con una sorta di lista della spesa di cose da vedere, che sappiamo essere in quel museo. Senza osservarle veramente, ma semplicemente per dire a noi stessi che siamo stati di fronte a quell’opera per qualche secondo e testimoniarlo ad amici e conoscenti. La visita al museo, come dici tu stessa, ha un po’ perso la sua funzione profonda.
Poi, in realtà, la riproducibilità tecnica è anche uno strumento per rendere le opere più accessibili. Magari, chi sta nella sala al Louvre è distratto di fronte alla “Gioconda”, ma in quello stesso momento - grazie alla possibilità di riprodurne l’immagine – in Cina può esserci un ricercatore che ha trascorso otto ore della sua giornata a osservare quell’ineffabile sorriso, senza la necessità di prendere un aereo e andare a Parigi. Certo, l’immagine non sostituisce la fruizione fisica di un’opera, ma comunque la rende presente anche dove non può esserlo fisicamente. E poi, le immagini possono essere zoomate, offrendoci una visione potenziata rispetto a quanto possiamo avere nella realtà. In questo senso, la riproducibilità è uno strumento che può essere sia fonte di distrazione che trampolino per approfondire in modo più puntiglioso e preciso.
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione