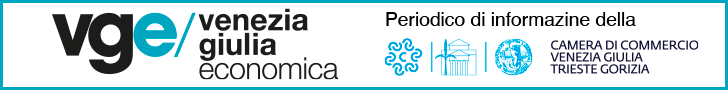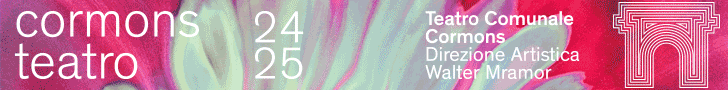la tradizione
L'amore per Sant'Anna specchio del tempo, tradizione e fede nel Goriziano

Nella giornata dedicata alla madre della Vergine, il racconto delle tradizioni popolari sul territorio firmato da Ferruccio Tassin.
A Romans, nel XVIII secolo, c’era un convento: le Sorelle della Dottrina Cristiana di Cormons, nate dalla iniziativa di Orsola Grotta, nobile locale, che voleva istruire le fanciulle (allora, una rarità; prima, nel Seicento, attive solo le Orsoline a Gorizia) vi crearono una filiale. In paese, mostrarono particolare devozione per S. Anna: le intitolarono la chiesa. Perché? A Romans, un motivo ulteriore, le aveva aiutate la contessa Anna Petazzi.
Per tradizione, confermata da ricchissima iconografia di opera d’arte più o meno famose (da Bainville a Giotto, Leonardo, Sansovino, Carpaccio e Murillo), S. Anna, Mater Matris Mariae, la madre della Madre (si intende Madre per eccellenza, del Salvatore) Maria, come la definisce sinteticamente una scritta in un quadro di Pietro Bainville, avrebbe insegnato a leggere la Sacra scrittura alla Madonna, la figlia, che è il suo primissimo attributo: Maria Bambina.
Pietro Bainville, pittore di Palmanova di origine francese (nel Settecento dipinse di qua e di là del confine, ispirato dalle committenti), mise tutto in evidenza tutto: le sante e i santi cui erano devote; che insegnavano a leggere e a scrivere, e che lo facevano con fanciulle di ogni condizione sociale. A queste suore è legata la Madonna di Rosa Mistica (ora delle Suore della Provvidenza): la statua del santuario, che avrebbe mostrato i primi prodigi a Romans. Amate dai locali, chiusero a Romans e cessarono il loro neppur secolare ciclo vitale a Cormons all’arrivo dei Francesi di Napoleone.
Nella cittadina longobarda lasciarono una scia di fanciulle col nome Anna e buona memoria. Il culto di S. Anna era popolare anche a Cormons, già dal Seicento, quando fu costruita (arcidiacono Del Mestri, 1636) la chiesa della B.V. del Soccorso, conosciuta col nome di S. Anna. Nel Settecento, si faceva una processione per la festa (26 luglio), forse legata alla invocazione di pioggia, benché il patrocinio più frequente fosse di protettrice legato alla maternità.
“Santa Ana empla la fontana”; “Santa Ana, riva la montana” e poi era uno degli sperati appuntamenti di piogge ben nutrite: “le montane”. A Cormons, acqua invocata… per il vino, in quell’epoca soprattutto la ribolla, prenotata da un anno all’altro da mercanti tedeschi. A Romans, nel convento (l’edificio esiste ancora), cantavano nel suo giorno fino a tempi relativamente recenti, culminando preghiere a Dio, alla Vergine e alla Santa.
Sennonché, da una analisi del testo, si è scoperto che il canto non era rivolto a lei, ma a S. Eurosia (martire, IX secolo), invocata contro il maltempo e per felici raccolti. Comunque, un legame col luogo c’era. È straordinario come di S. Anna ci sia stato culto precoce e intenso, nato in Oriente, propagato in Occidente, e come della sua vita si sappia poco o niente. Ciò che si sa è da vangeli apocrifi e dal “Libro della natività di Maria”; molto più tardi, dalla Leggenda aurea di Jacopo da Varagine.
Anna non poteva aver figli; detto in breve, per intervento divino, una figlia la ebbe, e che figlia! Fu maternità in maniera straordinaria: con un bacio, per osculum, tra lei e il marito Gioacchino, alla Porta Aurea di Gerusalemme (colà, nell’area del tempio, esistono i resti della casa). L’arte si impadronì della leggenda: rappresentazione pittorica perfino di Giotto (PD Cappella degli Scrovegni); a Gerusalemme una chiesa di S. Anna (1140) è su resti molto più antichi.
Sue basiliche e chiese furono erette in molti luoghi dall’antichità - Costantinopoli 530, e altra nel sec. VIII - fin nella Cappadocia e in Grecia sul Monte Athos. Culto presente a Napoli dal X sec., poi, pian piano si estese in ogni dove. Dante la celebra, stupefatta, nel XXXII canto del Paradiso: "...Di contr'a Pietro vedi sedere Anna,
tanto contenta di mirar sua figlia,
che non move occhio per cantare osanna...”. In Vaticano, c’è la parrocchia di S. Anna con la chiesa cinquecentesca cosiddetta “dei palafrenieri.
Numerosi sono i patrocini della santa, sulla vita ci hanno ricamato in maniera leggendaria: altri due matrimoni, discendenze mirabolanti, leggende stroncate dal Concilio di Trento. Diffuso in Europa, il culto fu portato dai Bretoni in Canadà. Atterriamo più vicini a noi culturalmente: diffuso nel mondo tedesco, in Austria ci sono 53 mete di pellegrinaggio, più significativo dei quali ad Annaberg a N di Mariazell. Per la verità, in tali pellegrinaggi c’era un uso che non si può definire il massimo d’eleganza verso le donne: offrivano in forma propiziatoria …rospi di metallo che, nella tradizione popolare, ricordavano le donne di parto.
Già migliore l’“Acqua di S. Anna”, per mali di testa, febbre, e altri mali. Pure in Italia non si scherza, a Lettere (Napoli), quando spostano la statua di S. Anna dalla nicchia all’altar maggiore, prima della festa, c’è, da parte della gente, la raccolta delle polvere! Siamo sul pericoloso bordo della superstizione; sui Santi, pose limiti il Concilio di Trento e Ludovico Antonio Muratori, abate e storico, scrisse nel Settecento “Della regolata devozione dei cristiani”.
È sempre rappresentata col mantello verde: ha portato dentro di sé la speranza del mondo… Patrona dei minatori (dalle viscere della terra si estraggono tesori; dalle sue viscere…); suocera del falegname Giuseppe e scrigno vivente della Vergine… protegge tutti quelli che lavorano il legno, fin i gioiellieri e i bottai. Insegnò a Maria a pulire la casa? Ecco protetti fabbricanti di scope; a tessere, i tessitori; a cucire, i sarti, come madre dei Maria Stella maris, è patrona dei naviganti…e poi delle madri di famiglia e delle vedove… Si capisce, delle partorienti e di quante chiedono figli.
Patrona della buona morte (le è consacrato il martedì, giorno della sua di morte): le sarebbe stata fatta grazia di risparmiarle i dolori dell’agonia. Legata all’acqua abbiamo visto; a Vinadio (Cuneo), c’è la fonte di S. Anna…; altre fonti o fiumi la richiamano. Ma là, probabilmente la fonte e la marca hanno preso nome dal celebre santuario. Da una rapida indagine sulla prima visita pastorale del I'arcivescovo di Gorizia Carlo Michele d’Attems (1752), escono numerose chiese col titolo di S. Anna nella parte slovena della diocesi; e numerosi gli altari.
Legata al mondo minerario la chiesa di Idria; per il mondo tedesco, quella di Cave del Predil. A Gorizia, c’era una cappella di S. Anna sorta nel 1334, ora inglobata nel duomo. C’è anche qualche titolo “mobile”, per esempio, quello dell’altare prima a Gorizia in duomo e ora a Mariano. Altare barocco, la pala con la Madonna che impara a leggere da sua madre è di Annibale Strata, un pittore dell’Ottocento. Romans: due S. Anne significative, una affrescata nell’abside della chiesa (Lorenzo Bianchini, 1876) e la campana “mezana”, battezzata nel 1947.
Feste a Dolegna, Gradisca. Quella di S. Anna a Gorizia ha più che altro tradizione mangereccia; la parrocchia ha questo nome perché lo aveva chiesto l’arcivescovo mons. Andrea Pangrazio dato che nel periodo di fondazione gli era morta la madre. Si veda che altari e chiese o cappelle hanno le origini più varie. Prendiamo la stanza di preghiera all’aereoporto di Ronchi, intitolata alla Santa.
Don Lorenzo Boscarol ci ha messo la foto di una statua della Santa a Gerusalemme, e il disegno di una ancona molto più antica: si trovava nei paraggi, vi si recavano a pregare le madri in attesa di un bambino, così come nella cappella di S. Anna a Visco e in numerose altri paesi, quando il parto era un dramma. Ben mescolato al folclore, quello antichissimo di origine celtica dei fuochi, il culto di S. Anna a Salars di Ravascletto (vi si conserva una reliquia, proveniente dalla cattedrale di Ancona, dove si trova una reliquia del piede destro).
La statua è portata in processione dalle fanciulle del paese; la sera, fuochi col lancio delle “cidules”. Chiese cimiteriali di S. Anna ce ne sono: una, a S. Marizzutta di Varmo (notizie dal ’300, su preesistenze romane), ma dedicazione da una vicina ancona della Santa, dove, nel ’500 sarebbero avvenuti “fatti straordinari”; qui è ancora in vigore una processione in suo onore.
La chiesa più antica e interessante, dedicata a S. Anna e a S. Andrea, è a Perteole: all’interno sono i resti dell’abside primitiva del IX secolo. Qui, legame con l’aspetto cimiteriale e con quello delle acque (ma per troppa abbondanza, non per carenza!), sottolineato dalla codedicazione a Sant’Andrea.
Nella foto: la pala d’altare del convento di Romans: in alto, la Trinità, poi le Suore di Carità, le fanciulle allieve, S. Anna e S. Caterina da Siena. Sia pure non firmata, la pala è certamente di mano di Pietro Bainville.
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) +39 328 663 0311.

Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione