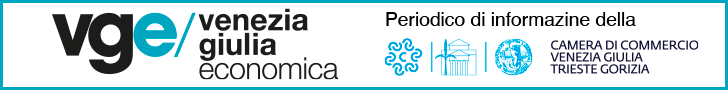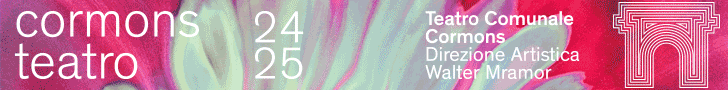L'INTERVISTA
Alessandro Comodin e il mestiere del cinema: «Fare un film è per me mettersi a nudo»

Mercoledì 23 aprile a Gorizia l’incontro con l’autore, in occasione della masterclass 'Lavorare la realtà per un’idea di cinema di frontiera' alla mediateca 'Ugo Casiraghi'.
Nato nel 1982 nel borgo medievale di San Vito al Tagliamento, Alessandro Comodin compie i primi studi universitari al Dams di Bologna, trasferendosi a Parigi con un Erasmus e in seguito entrando all’Institut Supérieur des Arts di Bruxelles. Nel 2009 si diploma con il cortometraggio “Jagdfieber” (“La febbre della caccia”, 21’), presentato al Festival di Cannes. Al documentario seguirà il lungometraggio “L'Estate di Giacomo” (2011, 78’), con cui ottiene il Pardo d’oro al Festival di Locarno e altri importanti riconoscimenti. Nel 2016 gira “I tempi felici verranno presto”, del quale è anche sceneggiatore e montatore, che vince il Beatrice Sartori Award al Festival di Cannes. L’ultimo lavoro lo conclude nel 2022 con “Gigi la legge” (102’), aggiudicandosi il Premio speciale della giuria al Festival di Locarno. Ha accettato l’intervista dal Goriziano anticipando alcune tematiche, che affronterà insieme al pubblico mercoledì 23 aprile alla mediateca Ugo Casiraghi di Gorizia. L’incontro, organizzato da Kinoatelje, inizierà alle ore 16 con ingresso gratuito.
Dopo due anni immersivi nella cineteca di Bologna, ottieni un Erasmus a Parigi, per poi iscriverti alla scuola di cinema di Bruxelles, dove a catturarti sarà il documentario. Come hai vissuto, quegli anni, e quali incontri ti hanno segnato?
«Gli anni dell’Erasmus a Parigi e della scuola di cinema a Bruxelles sono stati ricchissimi di scoperte. Il documentario è una di queste, ma ce ne sono state tante altre. Ero ben consapevole che studiare quello che mi piaceva fosse un privilegio, e oltretutto avevo l’appoggio di genitori che si sono sempre fidati di me, anche se non sapevano bene cosa stessi facendo. Avevo l’impressione di essere nel posto giusto, circondato da schermi di cinema bellissimi ed esigentissimi: dalla Cinémathèque française a quella di Bruxelles recuperavo film della storia del cinema che non conoscevo. Dopotutto, sono nato negli anni ‘80 e non avevo visto nulla. In più avevo la possibilità di accedere a film contemporanei che altrove e soprattutto in Italia non avrei mai potuto vedere. All’epoca Internet non era così sviluppato, quindi dovevo cercare fisicamente le pellicole in sala o in mediateca. Gli incontri più importanti sono quelli compiuti da ogni studente universitario, principalmente gli amici con cui condividi la tua passione. Che poi sono le persone con cui tutt’ora lavoro, con le quali ho scoperto e condiviso gli anni più incredibili della mia vita. Fra i professori, pochi mi hanno lasciato un segno. Due fra tutti: Eric Pauwels, regista belga che ha lavorato con Jean Rouch, e Thierry Odeyn, gran pedagogo e specialista del cinema di propaganda».
Pier Luigi Mecchia è tuo zio in “Gigi la legge”, che di professione è realmente vigile urbano a San Michele al Tagliamento. Già ne “L’Estate di Giacomo” compare Stefania Comodin, è tua parente? Come scegli, gli attori e in quanti giorni porti a conclusione i tuoi lavori?
«Pierluigi e Stefania sono rispettivamente mio zio e mia sorella. Per ora ho lavorato quasi sempre in una dimensione familiare, dove la frontiera tra arte e vita non esiste quasi più. Anche con i miei collaboratori formiamo una sorta di famiglia. La considero importante, mi sento protetto. Essendo io abbastanza pudico, ho bisogno della famiglia attorno per potermi spogliare completamente. Fare un film, per me, è come qualsiasi altra forma d’arte: mi devo mettere a nudo, mostrando nel modo più onesto possibile ciò che sono. Non posso fingere. Per un film del genere, per trovare il giusto equilibrio di semplicità e forza, ho bisogno di anni. Cinque anni è purtroppo la durata media del processo, per quanto mi riguarda. Ciascuno ha il proprio ritmo, però è vero che così facendo il film diventa per me segno di un’epoca della mia stessa vita. Un bimbo che nasce, una persona cara che scompare, una canzone...».
I tuoi film paiono “farsi da sé”, rinviando a un luogo che va oltre lo schermo, quasi abitassero in uno spazio temporale dissociato dall’autore. È una scelta stilistica che mira a trasporre la singola storia in una sorta di archetipo filmico?
«È bello quel che dici. Mi ci riconosco molto, anche se non lo faccio di proposito. I miei film assomigliano a quello che sono nella vita, al mio tono di voce, alla mia ironia quando parlo, al mio essere defilato nelle foto, perché sempre troppo grande rispetto agli altri… Il mio modo di lavorare è quasi plastico, per questo spesso scopro la motivazione profonda di un film solo a lavoro concluso. Svelo le forme a posteriori, dopo averle filmate. Ne sono spettatore e insieme autore. Pavese diceva che non vediamo mai le cose la prima volta ma sempre la seconda: così che non appena le vediamo, le scopriamo e assieme ce ne ricordiamo. È come se mi lasciassi attraversare dalla realtà e dal mio desiderio estetico irrazionale. Ne escono per forza energie archetipiche e irrazionali».
Per “L’Estate di Giacomo” (2011), pur abitando da anni a Parigi hai ambientato un racconto d’iniziazione adolescenziale nel Friuli del Pasolini poeta. Una terra fiabesca e incontaminata che si offre come cornice alla “rinascita” dello stesso attore Giacomo Zuliani, che aveva appena recuperato l’udito. Perché hai scelto un protagonista che realmente non era in grado di percepire i suoni prima d’allora? Che successo ha avuto, nelle sale francesi? C’è un’attenzione maggiore, ai cineasti, rispetto al nostro Paese?
«Ho scelto di fare il film perché dovevo farlo. Concluso il cortometraggio di diploma (“Jagdfieber - la febbre della caccia”) che sarebbe andato a Cannes di lì a qualche mese, avevo ricevuto in premio del materiale (una cinepresa 16mm e il suono) fondando con amici e colleghi un collettivo di produzione in Belgio (Les films nus, defunto da allora). D’estate rividi Giacomo dopo anni e mi raccontò che si sarebbe fatto operare, finalmente percependo i suoni per la prima volta in vita sua. Di certo uscivo dagli studi senza un lavoro. Il tutto messo assieme, sommava nella mia testa un film. Ho scelto senza scegliere, e senza sapere che così avrei realizzato il mio primo lungometraggio. Di solito i colleghi cineasti si preparano, cercano produttori, scrivono sceneggiature, contattano agenti, fanno cortometraggi…Io sono partito un po’ allo sbaraglio, col cuore aperto per un affresco adolescenziale estivo di provincia, senz’altri progetti che girare un bel film. Ho potuto farlo perché mi ritrovavo in un contesto, come quello di Bruxelles, dove era possibile immaginare un’impresa del genere. Non solo sotto l’aspetto di produzione, ma anche nella diffusione. È scontato che il fatto di essere passato da Cannes con il mio cortometraggio abbia facilitato le cose, e di certo solo in Italia non sarebbe stato possibile. Per fortuna in Friuli ho incontrato Alberto Fasulo e poi Paolo Benzi, che all’epoca lavoravano assieme e cominciavano a immaginare modi nuovi di produrre anche fuori dall’Italia. Che è un Paese molto totalitario in termini di produzione e diffusione, dove pare ci sia un unico modo di fare i film: per questo i prodotti italiani si somigliano più o meno tutti. La critica non esiste quasi più o non ha nessuna voce in capitolo. Il cinema in Italia è affare di persone di un ceto sociale agiato, dove per un ragazzo di provincia diventa impossibile anche solo immaginare di realizzare un’opera cinematografica. Almeno all’inizio degli anni 2000 era così. Oggi, venticinque anni dopo, mi pare che le cose non siano cambiate più di tanto».
Nel lungometraggio “I tempi felici verranno presto” (2016) indaghi il rapporto primigenio fra umanità e Natura. I protagonisti strisciano nelle viscere della Terra, si amano nel fango, attraversano la foresta alla ricerca delle proprie origini. Una ricerca ascetica con uno sguardo puro non dissimile dalla poetica di Robert Bresson, che come te ha lavorato con attori non professionisti. Il cane girovago fugge via quando i due vengono uccisi, mentre un asino trasporta Ariane sul suo dorso. Ricorda quasi “Au hazard Balthazar”, per il quale Bresson parlerà di «forza eiaculatrice degli occhi»…Ti riconosci, in questa stessa felicità narrativa?
«Bresson è una delle scoperte dei miei percorsi in giro per le sale oscure. “I tempi felici” è un grande omaggio a questo autore. Alla fine di “Pickpocket”, uno dei più bei film a livello mondiale, il protagonista in prigione dice alla sua innamorata: ‘Che strano percorso ho dovuto seguire per arrivare fino a te’. Bresson cercava la verità cinematografica attraverso l’artificio, l’epurazione di ogni realismo. Io cerco la verità attraverso un’accumulazione di verità documentaria. Cerchiamo la stessa verità percorrendo "strani percorsi” che sembrano antitetici».
Con “Gigi la legge” l’attenzione si sposta sulla staticità della vita di provincia, dove in un’estate soleggiata una ragazza decide di togliersi la vita. Ancora una volta ci restituisci la realtà friulana quale realmente è, quasi con sguardo documentaristico, montando appena 77 inquadrature. André Bazin, che coniò il termine “piano-sequenza”, diceva: «Il mondo semplicemente è». Si può dire altrettanto del tuo linguaggio filmico?
«Il piano-sequenza è per me l’unico modo per restituire quell’ambiguità, o quell’indecisione, che è data alla realtà. Io francamente tutti giorni vivo nell’indecisione tra realtà e desiderio. La realtà è, ma al contempo pare. Per ritrovare questo effetto magico che vivo nel quotidiano, non posso che cercare di restituirlo con blocchi di spazio-tempo unitari. Non credo al montaggio invisibile, ne vedo solo l’artificio. Credo invece alla trasfigurazione della realtà attraverso la realtà stessa».
Hai già concluso il lungometraggio “Serena”? Quali sono i tuoi prossimi progetti?
«“Serena” raccontava la storia di una giovane donna di provincia in un paesino del Friuli, che partiva per una vacanza per la prima volta sola in vita sua. Un ritratto della donna contemporanea che al cinema non viene mai proposto. E tuttavia, con molta probabilità questo film non vedrà mai la luce. Il ministero della cultura italiana, nonostante il sostegno di quello francese, ha stabilito che il film non valesse la pena realizzarlo, anche se sarebbe costato un quarto di un “piccolo film” medio italiano. Forse esiste ancora una remota possibilità, ma francamente non ci credo più. Gli italiani non se ne rendono conto, ma è in corso una dichiarata operazione di rimozione del cinema più artigianale e piccolo, di cui io sono umile rappresentante fra tanti altri, a scapito di autori e autrici giovani. La vulgata è che il ministero possa finanziare film in grado di portare guadagno, non questi che al botteghino non incassano nulla. Un’idea di efficacia economica lontana mille miglia dal servizio pubblico. I finanziamenti, come si legge nero su bianco, sono destinati esclusivamente a opere di grande portata in cui siano presenti attori noti, supponendo che il pubblico sia interessato soltanto a questo genere di cinema. Ritengo vi siano fattori più importanti dell’impatto economico sulla collettività. Di certo, al momento non posso più immaginare i miei film in Italia. Preferisco girare altrove, piuttosto che sottostare a costrizioni che non rappresentano in nulla la mia visione di società. La rappresentazione della realtà italiana verrà sempre più monopolizzata da una visione facsimile romanzata, basata s’uno storytelling medio. Nessuna sorpresa né accenti diversi, e nemmeno temporalità nuove e originali. Una questione di cui non si parla mai, concentrandosi soltanto sul denaro. In attesa di trovare il coraggio per girare “Serena” senza soldi, il fine settimana con i miei amici, il mio prossimo progetto lo farò in Francia».
Foto Locarno Film Festival/Ti-Press/Massimo Pedrazzini
Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.




Occhiello
Notizia 1 sezione

Occhiello
Notizia 2 sezione